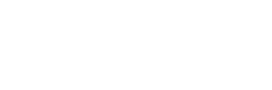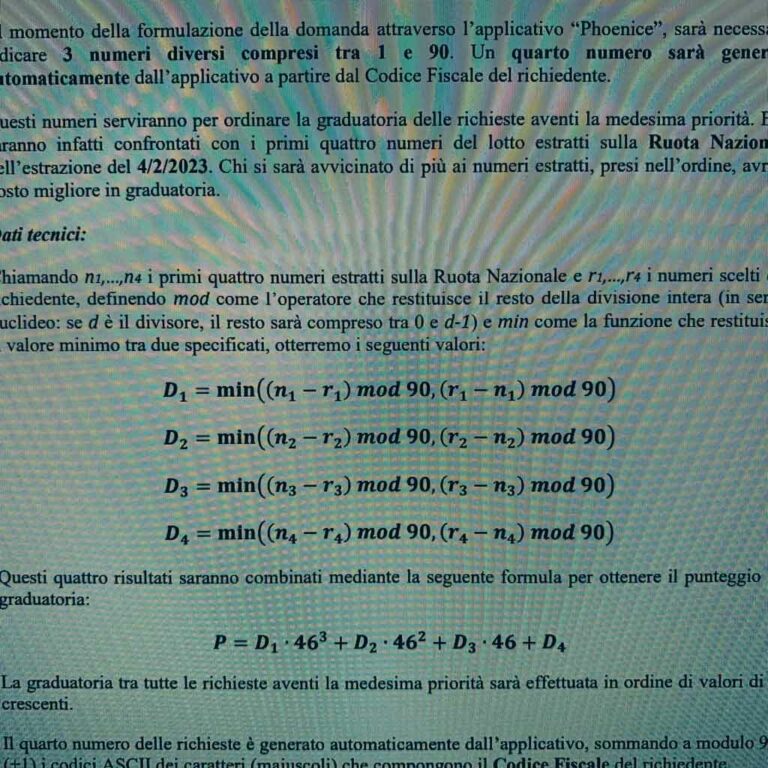Le guardie erano lì. Ne era certo, perché il gatto era nervoso: non si avvicinava al muro del giardino, continuando a guardare verso l’alto. Sentiva qualcosa. Sicuramente, oltre le verdi e spesse foglie appuntite dei rampicanti che arrivavano fino in cima, oltre la strada che stava al di là della barriera, sedevano gli uomini con lo stemma bianco e le lunghe spade. Guardò Arcil. Era bella; pallida. Avvolta nel manto di pelliccia, portava addosso solo l’abito bianco di seta con i simboli dorati del sole nascente, fissato con una cintura bianca e ornato da fregi di rame. I capelli neri, sciolti, le cadevano in modo disordinato sulle spalle e lungo la schiena. “Loro sanno”, le disse; non era una domanda. “Certo”, rispose, appoggiandosi a lui, la testa sul suo petto. Erano seduti sotto la quercia, sul tronco, più piccolo, di un albero sconosciuto e meno nobile caduto chissà quanti anni prima. Si tenevano per mano. Le sue mani, lunghe e affusolate; le sue dita delicate, quasi gelide durante l’inverno e fredde anche d’estate. Le mani calde e grandi di lui, piene di cicatrici, indurite dal duro lavoro.
“Tutti lo sanno”, gli disse, parlando piano. La sua voce era sempre bassa, quasi rauca: l’amava così tanto. “Quando vengo qui, nel parco, c’è sempre qualcuno che mi guarda. Che mi osserva, che pensa a me. Oggi ci sono i soldati. Ma non è sempre così. A volte c’è l’uomo che ripara il recinto, o l’ambulante che vende le mele, oppure la bambina che mi porta il miele, è tutto parte della mia vita. Lo è stato sempre. Sono tutti dell’Ordine. Le mie guardie del corpo”. Si accoccolò tra le sue braccia, sentendo il suo calore. “La città è mia. Il mio governo; il mio diritto”. “Sei ancora Arcil”, disse lui. “Solo per me”. La baciò dolcemente sulla sua testa, poi sulle labbra. “Sei la moglie del signore, ma non sei più una principessa, qui a Ostelar”, disse ancora. “Lo so”, rispose lei. “Ma lo sono stata per così tanto tempo, Thaen. Non riesco a fingere che non me ne importi”. “Tu volevi esserlo”, disse Thaen, “e tutto ciò che avevi ti spettava”. “Sì, lo desideravo”, rispose Arcil, “ma non più”. Thaen poteva sentire che era nervosa, ora; infastidita da quello che lui le aveva appena detto. Si sentiva in colpa; non voleva ferirla. Era complicata. Tutto, ora, con la presenza di Arakhon nella sua vita, era diventato così complicato. “E cosa desideri di più adesso, mia bellissima principessa”? Le accarezzò le spalle e le baciò dolcemente il collo, vincendole un sorriso. “Oh, ora mi stai prendendo in giro! Non è bello da parte tua”. Gli diede un colpo con il gomito. “Sono la tua signora, tu sei il mio cittadino e ti condannerò, ti farò frustare in piazza…”. “Solo questo?” La baciò ancora. “Lo farò di sicuro! Finché non mi pregherai di smettere… ma userò una frusta di fiori e un morbido arbusto, solo quello… e ti punirò con la lingua, dal tuo petto alla tua pancia e…”. “Capisco”; l’interruppe. Fecero l’amore all’ombra dell’albero, lentamente, in silenzio. Dolcemente. Sotto il suo mantello, senza spogliarsi.
“Non mi sento a mio agio, veniamo qui troppo spesso”, disse Arcil, sospirando. Erano ancora sdraiati sull’erba, avvolti nel mantello. Guardavano il sole, che si avviava al tramonto. “E perché”? Chiese Thaen. “Quando sei qui, quando siamo insieme, è il momento migliore della mia giornata. Sono così felice”. “Amore estivo. Si spegnerà con l’autunno”, rispose lei. Dentro di sé, in fondo all’anima, Arcil sentiva un dolore sordo; lasciò che passasse e lo abbracciò più forte. “Non lo è, Arcil. E tu lo sai”. Arcil annuì, ma il dolore tornò. “Dal momento in cui ti ho incontrato, mi sento bene. Se non ti avessi incontrato… non lo so. Forse sarei morta, ormai. Ero così sicura che sarei morta da sola. Volevo solo il silenzio, e svanire. Poi, sei venuto, è stato come… vedere di nuovo la luce. Si, è stupida come visione, però è così. Ho bisogno di te”. “Sono qui, principessa. Ma lui tornerà, Arcil. Tornerà a casa. E poi, cosa faremo”? Lei rimase silenziosa. Per un lungo momento. E Thaen, mentre aspettava, pensò che il suo cuore avesse smesso di battere. Poi Arcil parlò, calma, determinata. Arcil la principessa; Arcil, la regina di Ostelar. Come Thaen si aspettava che fosse.
“Continuerò a essere sua moglie, Thaen. La moglie di Arakhon. Non posso fare nulla di diverso. Potrei avere il potere di chiedergli di nuovo la mia libertà, di fronte ai magistrati e anche al Consiglio. I cittadini di Ostelar non mi incolpano di troppo. Arakhon è diventato una leggenda, eppure questo è il luogo in cui è nato e c’è chi ricorda gli anni di prima. Aveva anche altre donne, in tutte le Sette Terre, tutta la città lo sa… e ha figli avuti dalle sue amanti. Potrei lasciarlo. Potrei riprendermi, di diritto, i miei castelli”. Thaen, per un attimo, ebbe un fremito: sapeva cosa quella decisione poteva portare. “Ma non lo farò mai. Un ripudio della nostra unione spezzerebbe il suo potere e la sua influenza, e causerebbe nuovi disordini. Mi aspettavo che Arakhon reclamasse, finalmente, il trono dei Valdali, per la prima volta dopo secoli; e con me al suo fianco, lo avrebbe vinto, sarebbe diventato il re, un pari di Elessar, e io la sua regina. Ma lui mi ha delusa, Thaen… davanti a tutti. Ero in ginocchio, a piangere: l’ho supplicato. Di fronte al gran Re del Nord, di fronte a Elessar, Arakhon mi ha tradito. Ho persino pensato di mettere fine alla mia vita: ho pensato di chiedere al più fedele dei miei soldati di uccidermi, proprio lì, davanti a loro. Aginor è veloce e preciso: sa come arrivare al cuore con il suo coltello. Un momento, e tutto finisce”. Arcil fissava qualcosa di fronte a lei, un punto lontano nel cielo, o forse stava semplicemente guardando il nulla. Persa nella sua ritrovata solitudine. Si alzò, coprendosi il seno nudo e la schiena con il mantello di Thaen e lasciando il suo a terra; quando parlò di nuovo, la sua voce era più forte. “Ma siamo andati avanti. Negli anni, ho imparato a conoscere Arakhon, e lo rispetto. Non l’ho mai amato, e lui lo sa bene. Non l’amerò mai. Siamo troppo diversi. È un grande uomo durante il giorno, e un grande amante la notte, quando ne ho voglia. Non è mai cattivo, trovo in lui molta generosità. Di tutte le persone che ho incontrato nella mia vita, lui è l’unico che… è l’unico che definirei un uomo decente. E tu, Thaen, certo. Ma è anche rozzo, Arakhon: inelegante. Non è ignorante, no: ha studiato duramente per poter essere quello che è ora. Ha sofferto. Arakhon è un principe con i modi di un vaccaro. E balla come un vaccaro. Oh, mi piace molto ballare con lui, a volte… può far sentire importante una donna. Che è, per noi nella Terra dei Sette, cosa non comune. Spesso, c’è stato odio e amarezza fra noi: ma non più”. Si alzò, sistemandosi di nuovo e tirando la cintura sui fianchi, dando al vestito la forma del suo corpo. “Inoltre… non è un vero uomo, non è uno di noi. È di sangue misto: Arakhon è figlio di una donna che era, per parte sua, di pelle bronzea, una figlia bastarda di avventuriero. No, non ho amore per Arakhon: come potrei. Amo i figli che mi ha dato però: li amo così tanto, e questo è un motivo in più per donargli il mio rispetto: per la sua forza. Sono una donna fragile, Thaen, sono sempre stata fragile. Tutti mi hanno detto che sarebbe stato molto difficile per me avere un figlio. Ma Arakhon ha un seme forte: non pensavo di poter esser madre, ma ho fatto invece in tempo, prima che il mio corpo diventasse ciò che è adesso. No, non lo amo, Thaen. Amo te. Ma devo stare con lui. Voglio”.
“E se dicessi di no, Arcil?”, chiese Thaen. “E se me ne andassi di nuovo in mare? Come posso trovare la forza per vivere qui, sapendo che non posso incontrarti e stringerti e baciarti quando desidero farlo? Sapendo che non posso parlare con te quando tu e Arakhon siete assieme. Devo continuare a fingere di conoscervi solo come i miei padroni, e sperare che nessuno gli dica la verità? Meglio andar via”. “Mi spezzerai il cuore, allora. Mi spezzerai. Non immaginerei mai di poter amare un altro uomo, dopo tutto quello che è successo. La mia sofferenza, le lacrime. Dormire di notte, sognare di esser felice, poi svegliarmi nella mia stanza, da sola, al buio. Piangendo. Non possiamo stare insieme, Thaen; ma non possiamo separarci, no, non voglio pensare che te ne andrai… ma… capisco. Se lo fai, capirò”. Stava piangendo, ora. Per un altro lungo momento rimasero di nuovo in silenzio. Guardandosi l’un l’altro. La strinse di nuovo: l’afferrò per la vita, caddero e rotolarono sull’erba. Risero fino a restare senza fiato, lui supino e Arcil sopra di lui. “Ti amo. Rimarrò, Arcil; per sempre. Non importa cosa farai. E non ti chiederò mai qualcosa che non sei pronta a dare”.